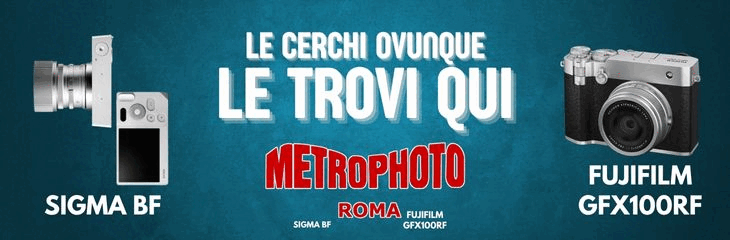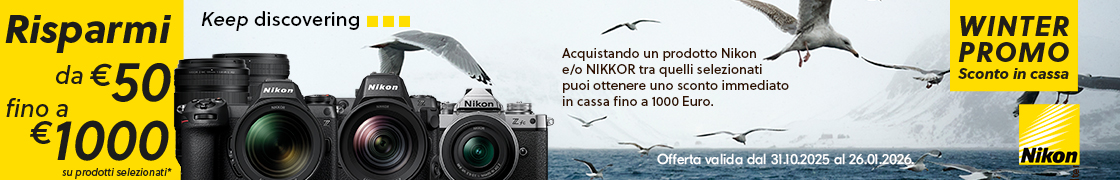Giovani Kichwa fanno la guardia vicino ai caterpillar destinati a scavare la foresta per la costruzione della centrale idroelettrica di Genefran sul fiume Piatúa. Il progetto non è stato sottoposto a una consultazione preventiva, libera e informata da parte della comunità di Santa Clara, come previsto dalla Costituzione dell’Ecuador. I lavori preliminari di costruzione di Genefran sono stati bloccati dagli oppositori indigeni in difesa del fiume Piatúa, la principale fonte d’acqua della comunità. Il Piatúa, un affluente del Rio delle Amazzoni situato nella regione di Pastaza, in Ecuador, si pensa abbia milioni di anni e ospita una delle aree più ricche di biodiversità del mondo, con specie di flora e fauna ancora sconosciute. Per gli indigeni Kichwa di Pastaza, il fiume Piatúa è sacro: è un essere vivente, venerato e temuto, amato e protetto.
Da decenni la foresta pluviale dell’Ecuador è tormentata dallo sfruttamento selvaggio dei giacimenti di petrolio e dall’estrazione mineraria. Le due attività procedono inarrestabili per vie perlopiù illegali, noncuranti dei mostruosi disastri ambientali che generano in corsa. Sversamenti, deforestazione ed estrazione non regolamentata stanno distruggendo una delle regioni più ricche di biodiversità del mondo, contaminandone l’acqua e la terra con mercurio, altri metalli pesanti e rifiuti tossici. Compagnie straniere ricevono concessioni governative non autorizzate e si arrogano il diritto di sottrarre territori alle comunità indigene, sconvolgendo lo stile di vita di interi popoli, contemporaneamente minacciati dalle organizzazioni criminali violente che sfruttano le risorse della foresta.
In questa sequela di soprusi impuniti, gli indigeni dell’Amazzonia ecuadoriana lottano tenacemente per le loro terre e portano avanti battaglie legali senza precedenti, come la ultraventennale azione collettiva contro il gigante petrolifero Chevron-Texaco, responsabile dello smaltimento negligente di almeno sessantotto miliardi di litri di rifiuti tossici e sessantaquattro milioni di litri di petrolio greggio, scaricati in fiumi e pozzi della foresta pluviale inquinando falde acquifere e terreni agricoli di un’area di 4.400 chilometri quadrati. Questa gravissima vicenda, soprannominata la “Chernobyl dell’Amazzonia”, ha minacciato la vita e il sostentamento di numerose comunità indigene, piccoli agricoltori e innumerevoli specie di flora e fauna.
La mano di Donald Moncayo mostra la prova dello smaltimento negligente di petrolio da parte della Texaco, scaricato circa 48 anni fa in una delle tante piscine di rifiuti che circondano il pozzo petrolifero di Aguarico (AG-04), nella provincia di Sucumbíos. Moncayo, membro di spicco dell’Unione delle Persone Colpite dalle Operazioni Petrolifere della Texaco (UDAPT), racconta che il gigante petrolifero (ora di proprietà della Chevron) si limitò a coprire le piscine di rifiuti petroliferi altamente tossici con della terra e ad abbandonare il territorio. La famigerata operazione di Texaco nelle province di Orellana e Sucumbíos, con cui la compagnia estrattiva ha scaricato rifiuti petroliferi tossici nei fiumi e territori indigeni della foresta amazzonica ecuadoriana, ha inquinato un’area del nord dell’Ecuador all’interno della quale centinaia di persone sono successivamente morte di cancro. L’UDAPT è un’organizzazione senza scopo di lucro che riunisce comunità appartenenti a sei nazionalità indigene (Waorani, Siekopai, Siona, Kofán, Shuar e Kichwa) e circa 80 comunità contadine insediate nell’area contaminata dalla transnazionale Chevron-Texaco. Nel 1993, il sindacato ha avviato una class action contro la compagnia petrolifera per i danni causati nelle province di Sucumbíos e Orellana, nell’Amazzonia ecuadoriana.
Piatsaw: il progetto fotografico di Nicola Ókin Frioli
Dal 2015 al 2023 il fotografo italiano Nicola Ókin Frioli ha documentato il modello di resistenza ambientale delle popolazioni native dell’Ecuador, producendo un progetto a lungo termine intitolato Piatsaw, come il nome del potente Spirito (Divinitá e Patriarca) che – secondo gli antenati Sápara – avrebbe creato il mondo Sápara, profetizzandone anche la fine. Soggiornando a lungo tra le comunità amazzoniche, l’autore ha voluto omaggiarne l’impegno incrollabile e testimoniarne gli abusi sopportati, nonché le precarie condizioni di salute dovute alla contaminazione di flora, fauna e falde acquifere di vasti territori.
Nella presentazione del suo progetto il fotografo menziona diversi successi delle iniziative legali portate avanti dalle nazioni indigene dell’Ecuador per salvaguardare la foresta, come la restituzione legale del territorio Shuar di Nankints dopo tre giorni di scontro armato impari con i militari. Le comunità della nazione indigena Shuar erano state vittime di uno sfratto forzato appoggiato da un governo complice delle multinazionali cinesi dell’estrazione del rame.
Le immagini e le didascalie del fotografo citano anche l’azione collettiva contro la Chevron-Texaco di cui sopra e la vittoria (non riconosciuta) della nazione indigena Waorani nel referendum nazionale del 2023, per impedire alla Petroecuador di trivellare nel Blocco 43 del Parco Nazionale del Yasuní.
I bianchi e neri incisivi di Nicola Ókin pubblicati in questo articolo sono accompagnati dalle dettagliate didascalie redatte dallo stesso fotografo. Per visualizzarne il contenuto è sufficiente fare clic sul testo che segue ciascuno scatto e immergersi nella storia di una battaglia che merita di essere raccontata e “ascoltata” con cura.
Un elicottero dell’Esercito ecuadoriano (AEE) decolla dal campo di calcio di una scuola nella parrocchia di San Juan Bosco, provincia di Morona-Santiago, Ecuador. Per alcuni giorni, l’Esercito ha tenuto il suo quartier generale nella scuola per attaccare i residenti della comunità Shuar di Tsumtsuim, che avevano deciso di recuperare il loro territorio dopo uno sfratto forzato dalle loro case a Nankints nell’agosto 2016. Secondo i rapporti ufficiali della Confederazione delle nazionalità indigene dell’Ecuador (CONAIE), l’Esercito ecuadoriano ha condotto un’operazione repressiva a sostegno della compagnia mineraria cinese ExplorCobres S.A. (EXSA), affinché potesse avviare le attività estrattive nel territorio di Nankints, settore Panantza, provincia di Morona-Santiago.
Gruppo di indigeni Shuar impegnati nella resistenza a Nankints durante gli scontri tra i membri della comunità Tsumtsuim e i militari. Aspettano il segnale radio che chiede loro di dispiegarsi verso il fiume Zamora, dove avrebbe avuto luogo lo scontro.
Donne indigene in prima linea, contrastano a mani nude gli scudi della polizia antisommossa durante uno scontro tra manifestanti e forze dell’ordine in Plaza Grande, a Quito. La protesta ha voluto denunciare l’attacco militare e la repressione del governo di Nankints che, favorendo le attività estrattive delle imprese cinesi, ha mantenuto uno stato di eccezione nella provincia di Morona-Santiago.
La devastazione della foresta pluviale intorno al fiume Jatunyacu, nella provincia di Napo in Ecuador, causata dall’estrazione illegale dell’oro perpetrata da gruppi criminali. Le fosse di scavo sono abbandonate colme di mercurio e altri rifiuti tossici. Nell’ultimo rapporto del Progetto di monitoraggio dell’Amazzonia andina (MAAP) e della Fondazione Ecociencia, Napo è la provincia con la maggiore espansione mineraria legale e illegale. Fino al 2021, quasi 1.125 ettari erano dedicati a questa attività, con un aumento del 316% in meno di 6 anni. Lo studio sottolinea che “l’attività mineraria è un’importante causa diretta di deforestazione”, provoca il 46% della perdita di foreste, oltre a inquinare i fiumi e a generare un impatto negativo sui mezzi di sussistenza degli indigeni.
Gloria, con il figlio in braccio, contempla dalla sua casa la valle che si estende a ovest della comunità di Tsumtsuim, solo sette mesi dopo il loro sgombero forzato a Tsumtsuim. Il 14 dicembre 2016, la provincia di Morona-Santiago è stata dichiarata in stato di eccezione, in seguito all’attacco armato di un gruppo Shuar al campo minerario di Nankints. La comunità di Tsumtsuim è stata attaccata da centinaia di soldati che hanno sparato ad alcuni dei residenti. Le ventisei famiglie che componevano questa comunità sono state costrette a fuggire, ad abbandonare le loro case e a rifugiarsi nella foresta scoscesa. Attualmente, in Ecuador, più di 41.769 ettari di foresta amazzonica sono stati concessi dal governo ecuadoriano a compagnie minerarie straniere.
Genesis, cinque anni, gioca tra le condutture petrolifere vecchie ma ancora in uso della Petroecuador (ex Texaco), che corrono a pochi metri dalla porta della sua casa nella periferia di El Coca, nel nord dell’Amazzonia ecuadoriana. La madre di Genesis, Monica, ha il cancro e uno degli altri due figli è nato con una malattia congenita. Monica dice che alcune notti il rumore prodotto dal pompaggio del petrolio è insopportabile. Sostiene inoltre che nel 2013, a valle, questi tubi sono stati responsabili di una fuoriuscita di petrolio, ma il personale di Petroecuador nega tutto, sostenendo che si tratta solo di tubi dell’acqua.
Nel 2018 Kevin aveva nove anni ed era l’unico bambino di una comunità A’i Kofán di Alto Bermejo, dove tre anziani sono rimasti isolati a molte ore di distanza nella giungla amazzonica. Kevin non ha mai saputo chi fosse suo padre e sua madre è morta. Il ragazzo è sotto la responsabilità degli anziani e, grazie alla convivenza con loro, ha ricevuto un’educazione ancestrale, autentica e profonda. La sua famiglia, composta dai tre anziani, ha deciso che la sua educazione non sarebbe stata quella dei comuni bambini delle città, di un “cucama” (termine che significa “guscio vuoto” e si riferisce all’uomo bianco), ma piuttosto quella ancestrale del popolo A’i Kofán. Una forma di resistenza contro le attività estrattive che rischiano di far scomparire la loro identità culturale.
Una colonna di fumo si leva da un incendio di pneumatici appiccato dai manifestanti indigeni nella comunità di Santa Clara, nei pressi del fiume Piatúa. La comunità non ha accettato lo scavo della foresta per la costruzione dell’impianto idroelettrico di Genefran. Le centrali idroelettriche danneggiano gli ecosistemi fluviali nativi modificando le proprietà fisiche, chimiche e biologiche del fiume; causano la perdita di habitat alterando gravemente il flusso dell’acqua (essenziale per mantenere le condizioni ambientali delle specie) e impediscono la riproduzione della fauna. Inoltre, colpiscono le popolazioni umane che dipendono dai fiumi per la loro sussistenza, come gli insediamenti indigeni amazzonici, alterando i modelli di pesca, irrigazione e navigazione, oltre a inquinare l’acqua con sostanze chimiche industriali tossiche.
Una donna guarda all’interno di un finestrino di un monomotore appena atterrato nella comunità di Morete nel territorio di Sápara. Morete, come altre comunità di questo territorio, può essere raggiunta solo per via aerea, poiché il fiume Conambo non è navigabile in nessun periodo dell’anno. L’arrivo di un piccolo aereo è quindi un evento speciale, un contatto con il mondo esterno. Le guerre di confine del 1941 tra Ecuador e Perù e il conflitto dell’Alto Cenepa del 1995 hanno diviso la Nazione Sápara tra ecuadoriani e peruviani. I Sápara sono i proprietari ancestrali del più grande territorio indigeno dell’Amazzonia ecuadoriana. Attualmente in questo territorio vivono anche comunità kichwa, alcune delle quali hanno iniziato a considerare il lavoro alle petroliere, come una soluzione alla loro instabilità economica, senza rendersi conto del grande impatto sulla salute, della distruzione e della morte che provocherebbe nel loro ambiente. Non lontano da Morete, nel Blocco 10, una nuova concessione petrolifera minaccia la vita di diverse comunità indigene Sapara e Kichwa, mettendo a repentaglio culture che vivono in stretto rapporto con l’ambiente in cui vivono, nonché il futuro e l’integrità della foresta.
Ulteriori immagini e informazioni sul lavoro di Nicola Ókin Frioli sono disponibili sul suo sito nicolaokinphotography.com.

Bio e contatti
Nicola “Ókin” Frioli (1977) è un fotografo italiano, autodidatta, freelance, documentarista e ritrattista, con vent’anni di esperienza. Ha studiato arte all’Università dell’Immagine di Milano (2004) e ha pubblicato su importanti testate, come The Washington Post, Time Magazine, The Guardian, STERN, El País Semanal e Geo. Ha seguito corsi di formazione per la copertura dei rischi e ha realizzato reportage su questioni ambientali, diritti umani e migrazioni in Messico, Ecuador e Pakistan. Le sue immagini sono state esposte in Canada, Francia, Italia, India, Giappone, Messico, Marocco, Paesi Bassi, Turchia, Spagna e Stati Uniti. Il suo progetto “Piatsaw” ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui una menzione “Award of Excellence” nella categoria “World Understanding Award” del Pictures of the Year (POY) 2024, il premio principale “Best Author of the Year” ai Siena Photo Awards 2024 e una menzione d’onore nella categoria Climate Change del Bar Tur Photo Award 2023.
È stato selezionato per la proiezione al Visa pour l’Image Festival di Perpignan (2023); è stato finalista al Premio Ponchielli; al Deeper Perspective-International Photography Awards (2023); al World Report Award nella categoria Spotlight e al Nannen Preis di Amburgo (2020). È stato titolare della Fundación BBVA Bancomer Arts Fellowship for Cultural Development (2014).
La Germania rade al suolo paesi, chiese e foreste per il carbone: ecco lo struggente reportage di Daniel Chatard
Il fotografo franco-tedesco Daniel Chatard documenta...
Da Chernobyl a Fukushima: i luoghi più inquinati dalla follia umana nel mirino di Pierpaolo Mittica
Living Toxic di Pierpaolo Mittica racconta...
C’era una volta il Nagorno Karabakh: il fotoreportage di un Paese cancellato dalla faccia della Terra
"C’era una volta il Nagorno Karabakh"...
Connessioni primordiali
Francesco Lopazio evoca legami ancestrali tra...