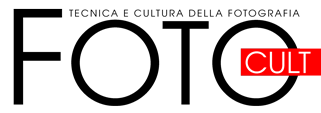In macrofotografia la profondità di campo non è mai abbastanza. Chiudere il diaframma non è sempre la scelta migliore: la diffrazione è in agguato e anche la qualità del bokeh ne risente. Ma non disperiamo: se il soggetto non ha fretta di andar via, viene in soccorso la tecnica del focus stacking.
In macrofotografia, genere in cui si ha a che fare con rapporti di ingrandimento molto elevati, la profondità di campo si riduce drasticamente. Un solo esempio: riprendendo con una reflex a formato pieno equipaggiata di obiettivo macro da 105mm un soggetto a 30cm di distanza dal piano focale (pellicola o sensore che sia) e regolando il diaframma a f/16, la profondità di campo è di appena 5mm, equamente distribuita davanti e dietro il piano di messa a fuoco. Chiudendo ulteriormente il diaframma a f/32 la zona nitida si estende fino a 10mm, ma di sicuro incappiamo nella diffrazione, un’aberrazione che si manifesta quando i raggi di luce passano attraverso un foro di piccole dimensioni. Quindi il guadagno in profondità di campo lo perdiamo sul fronte della nitidezza. Senza considerare che le zone che comunque resteranno fuori fuoco assumerebbero un aspetto (il bokeh) poco gradevole. In questi casi ai tempi della pellicola si poteva ricorrere alla complessa tecnica della macrofotografia a scansione, laddove il soggetto veniva illuminato da una lama di luce (lineare o circolare) proveniente da un illuminatore solidale con la fotocamera; il soggetto, ovviamente statico, veniva fatto scorrere a velocità lenta e controllata durante una posa B: una sorta di scansione ante litteram. Oggi il computer ci dà una mano, rendendo possibile con relativa facilità la tecnica del focus stacking (letteralmente, stratificazione dei piani di messa a fuoco), quindi la combinazione di più immagini realizzate in sequenza, con minime variazioni della messa a fuoco tra uno scatto e l’altro.
La tecnica del focus stacking consente di incrementare notevolmente la profondità di campo attraverso la fusione di più scatti, ognuno eseguito dopo aver spostato di poco il piano di messa a fuoco, ossia quello nitido. Anziché agire sulla ghiera di messa a fuoco, fissare l’intero sistema su una staffa micrometrica e agire su quest’ultima è una buona soluzione per limitare le variazioni dimensionali del soggetto causate dalla variazione di lunghezza focale provocata, specialmente, dai moderni sistemi di messa a fuoco interna. Un prodotto di qualità può arrivare a costare anche qualche centinaio di euro, ma volendo procedere “con cautela”, a buon mercato si trovano prodotti validi per sperimentare la tecnica. La foto in alto è stata realizzata fondendo assieme 13 immagini catturate con una Nikon D200 e il 105mm Micro Nikkor montati su una staffa micrometrica economica (meno di 15 euro).
Focus stacking: come fare
Analogamente ad altre tecniche multiscatto, come l’HDR o la fotografia panoramica, dove di ogni fotogramma viene presa la zona utile, nel focus stacking l’immagine finale è data dalla somma delle parti a fuoco di ciascuna immagine. La fusione degli scatti, che avviene al PC tramite software dedicati il cui funzionamento è quasi del tutto automatizzato, non impegna oltremodo il fotografo; più intricata è invece la fase di ripresa, dovendo sommare alle già complicate regole che governano la macrofotografia, anche quelle che consentono una corretta realizzazione della sequenza di scatti. Ad esempio, bisogna quantomeno considerare la variazione del rapporto di ingrandimento alle varie distanze di messa a fuoco; il fenomeno è legato alla variazione dell’elicoide del diaframma, che introduce un mutamento progressivo della focale e di conseguenza dell’ingrandimento del soggetto all’interno del fotogramma; molto evidente in macrofotografia, è ovviabile (almeno in parte) fissando la messa a fuoco su un punto e muovendo la fotocamera lungo una staffa micrometrica (il metodo è quanto di più simile alla macrofotografia a scansione di analogica memoria); se ne trovano a pochi euro online, ovviamente di qualità non paragonabile a quella di prodotti professionali, ma per sperimentare è una spesa che vale la pena affrontare. Ovviamente i software di fotoelaborazione sono pensati per tener conto del problema, e a fronte di un leggero crop correggono in automatico il “difetto”. I più preparati avranno quindi già dedotto quanto sia opportuno allargare l’inquadratura rispetto alla composizione ritenuta ottimale.
Questo è un articolo premium.
Registrati e leggi gratis per 30 giorni! Non è richiesta carta di credito.
ACQUISTA FOTO Credit
Preferisci non abbonarti?Acquista i tuoi FOTO Credit e sblocca solo gli articoli Premium che ti interessano!