L’Associazione Scatto Libero di Roma entra in contatto con realtà socialmente “difficili” e con la fotografia aiuta le persone che vivono situazioni di difficoltà a trovare la loro espressione, un modo creativo per ascoltare la loro voce, in carcere o anche in case famiglia. Ne abbiamo parlato con Tania Boazzelli, presidente di Scatto Libero.
Come nasce l’Associazione Scatto Libero e con che intenti?
In realtà nasce prima come un mio pensiero nella testa, in un periodo particolare della mia vita in cui ho abbracciato la fotografia come si farebbe con un salvagente. Partendo, quindi, dall’uso del mezzo fotografico come aiuto esistenziale ho pensato che potesse avere lo stesso effetto anche sugli altri, su quelle persone che, in difficoltà, hanno bisogno di scoprire un altro modo per esprimersi, oltre che con le parole. Così tramite una mia conoscenza siamo entrati dentro al carcere – nello specifico nella Terza Casa Circondariale, sezione maschile, di Rebibbia – non fotografando noi, ma attivando dei laboratori e degli incontri con i detenuti sulla fotografia. Il primo progetto, nel 2017, è stato Progetto Pellicola durante il quale ai detenuti è stata data una macchina fotografica analogica per raccontare la loro quotidianità dentro il carcere, con il pieno sostegno da parte della direttrice del carcere e degli educatori. Hanno partecipato in quindici e abbiamo preso per ogni ragazzo tre scatti, stampandoli (un 30×40 e due 18×24) e poi esponendoli.


Che reazione hanno avuto i detenuti alla proposta del progetto?
Durante il primo incontro che abbiamo fatto eravamo guardati da occhi un po’ impauriti, distaccati, perché pensavano che il progetto fosse un nostro racconto fotografico sulla quotidianità di un carcere, e non avevano capito che, invece, il nostro intento era proprio quello di ribaltare la soggettiva e dare a loro stessi la possibilità di raccontarci la loro quotidianità. Dopo aver spiegato questo “dettaglio” l’atmosfera si è sicuramente alleggerita.
Che indicazione avete dato a loro prima di fotografare?
All’interno di un carcere non c’è niente, ma chi ci vive sa cosa c’è di importante. Fotografando, sono andati alla ricerca di quei luoghi che appartenevano alla loro quotidianità, nei loro “posti affettivi”. Abbiamo suggerito di seguire questo filone narrativo.
E dal punto di vista pratico?
Li abbiamo lasciati all’istinto. Avevano in mano una macchina fotografica usa e getta, molto facile quindi da utilizzare. Guardi e scatti. Però, li abbiamo introdotti al lavoro di qualche fotografo noto, per dar loro qualche riferimento.

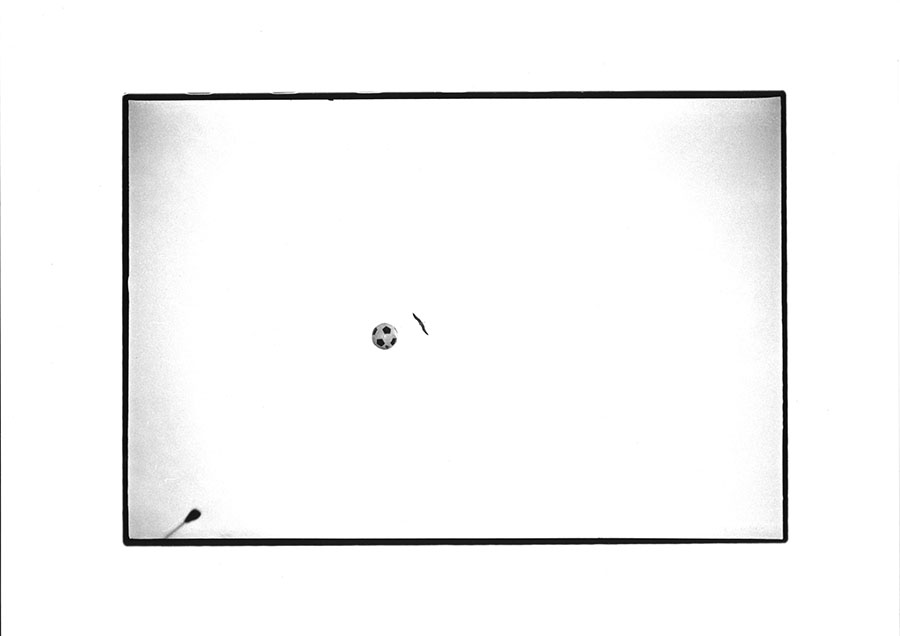
Prima ci raccontavi che le fotografie prodotte sono state esposte. Dove?
Sul muro esterno del carcere. Abbiamo pensato che fosse anche molto simbolico, idealmente era come se volessimo abbattere quel muro. Nel frattempo un ragazzo che ha partecipato al progetto era uscito e ha potuto vedere anche le immagini esposte esternamente. È stato un bel raccordo.
Hanno fotografato solo luoghi o ci sono, ad esempio, anche ritratti di persone?
Anche ritratti, certo. Persone che facciano parte di una loro routine quotidiana. Tanti hanno fotografato i gatti del carcere, che per loro rappresentano una vera compagnia. C’è chi ha fotografato un canarino, venuto da fuori e “addomesticato”, tenuto sulla spalla o comunque sempre portato con sé, anche quando facevamo lezione. La loro idea di “sopravvivenza” è quella di rendere affettivo un mondo che altrimenti sarebbe molto “freddo” e scomodo.



Progetto Pellicola è stato, quindi, il primo progetto. Ce ne sono stati altri in seguito?
Sì, assolutamente. In carcere, a Rebibbia, dovevamo starci solo un anno, ma in realtà, un po’ perché anche noi ci siamo affezionati al gruppo e alla loro realtà, siamo rimasti altro tempo, portando avanti altri due progetti. Uno sulla violenza sulle donne che è diventato anche una mostra, Come rami intrecciati, alla Casa della Memoria a Roma, l’altro, Ritratto di famiglia, ancora inedito, racconta degli incontri con i parenti e le famiglie nel weekend.
Cosa è emerso dal laboratorio sulla violenza di genere?
Il messaggio che ne è emerso è sicuramente il fatto di rendersi partecipi contro la violenza sulle donne. Hanno usato me e una collega come modelle, simbolo per rappresentare questo concetto. A corredo delle loro immagini sono state scritte, inoltre, delle poesie da un membro dell’Associazione, Arzachena Leporatti, e una poesia da un’assistente del carcere.
Avete fatto un laboratorio anche con il fotografo Alessandro Penso, usando le Polaroid. Perché l’utilizzo della Polaroid?
Anche per una questione prettamente pratica. Nel senso che Ars Imago, rivenditore di materiale analogico per la fotografia, ha messo a disposizione le macchine fotografiche e Polaroid ci ha regalato le cartucce. Quindi abbiamo sfruttato questa disponibilità e Alessandro è stato contento dell’idea. È stato un progetto articolato, composto non solo dal momento dello scatto, ma anche da un ulteriore atto creativo sopra l’immagine prodotta da parte dei detenuti. Infatti, un elemento aggiuntivo all’immagine sono state le frasi e le inserzioni scritte sopra, come se l’immagine prendesse voce, la loro voce. Il risultato del laboratorio con Alessandro ha dato luce non solo a delle immagini, ma a delle immagini più un concetto, espresso non solo dal linguaggio fotografico, ma anche dalla scrittura e dalla matericità della Polaroid.
Le immagini prodotte, la loro composizione, la resa finale con l’aggiunta scritta, sono tutti passaggi studiati a priori, pre-visualizzati da ogni ragazzo, insieme ad Alessandro. Tutta la progettualità di questo laboratorio ha portato ad un pensiero consapevole sulla fotografia da parte dei detenuti.
Alessandro è stato bravissimo a spiegare ad ognuno di loro come usare il mezzo seguendo la loro idea narrativa.
È stata, recentemente, pubblicata da Fugazine una fanzine con le immagini dei detenuti della Terza Casa Circondariale di Rebibbia, Così nun me scordo. Come è nata questa collaborazione?
Volevamo fare una “zine” con le immagini prodotte durante i nostri progetti in carcere, ma non c’eravamo mai riusciti per questioni di tempo. Tramite un contatto sono arrivata a Paolo Cardinali di Fugazine. Paolo ha, poi, avuto accesso a tutti gli scatti dei ragazzi – non solo quelli che avevamo selezionato noi per la mostra sul muro del carcere – e da quel corpus di immagini è partito per produrre un suo editing che ha dato vita a Così nun me scordo, inserendo, oltre alle fotografie, anche degli elementi scritti che sono frasi che i ragazzi dicevano durante il laboratorio. Il titolo, infatti, è la frase di uno dei partecipanti, riferita all’esperienza del laboratorio.
La maggior parte delle immagini prodotte dai vostri laboratori e progetti sono in bianco e nero. Perché?
Il bianco e nero è stata una scelta dettata dalla mia voglia di stampare, io stessa, le immagini e inoltre, secondo me, si sposava bene con la narrazione del carcere, dava giustizia all’intensità di questa esperienza.
Perché avete pensato che proprio il linguaggio fotografico fosse adatto a far raccontare una realtà sociale come il carcere?
Il linguaggio fotografico è espressione forte di chi, magari, non ha voglia di parlare. In carcere non tutti hanno voglia di parlare. L’immagine fotografica traspone visivamente anche le urla. I ragazzi, con le foto che hanno prodotto, sono stati liberi di urlare.
La vostra progettualità con realtà socialmente “difficili” si focalizza unicamente su carcere?
Siamo stati, ad esempio, anche alla Repubblica dei Ragazzi, una casa famiglia a Civitavecchia. Dopo aver lavorato per tre anni con la realtà carceraria abbiamo pensato alla possibilità di usare un metodo simile anche in altre dimensioni e così siamo arrivati lì. Non avevamo mai lavorato con adolescenti e bambini, non è stato facilissimo soprattutto per la loro giovane età e per una gestione dell’attenzione molto più complessa. Come in carcere abbiamo portato le macchine fotografiche, ci ha aiutato il fatto che i ragazzi fossero già avvezzi alla produzione di immagini con il telefono, ma il processo dell’analogico era comunque, per loro, una realtà nuova che li ha messi in contatto con l’origine dell’immagine, con la matericità, e li ha portati a capire i meccanismi di una macchina fotografica. La cosa che ci ha fermato è stato, indubbiamente, la pandemia. Dopo sei mesi che eravamo a Civitavecchia il Covid ha chiuso ogni progetto e quando avremmo potuto tornare, a fine pandemia, molti ragazzi non erano più in casa famiglia e quindi si è un po’ disperso tutto.
Ulteriori informazioni sull’Associazione Scatto Liber sono disponibili sul sito scattolibero.org.

Frank Horvat
Per le sue immagini Frank Horvat, ironico, poliedrico e instancabile sperimentatore, si serve di numerosi “vocabolari”. La ricerca di nuovi ...

Edward Burtynsky
“Il fatto che riesca a deliziare l’occhio e la mentre allo stesso tempo, e a piantare il seme del dubbio ...

Kurt Moser, Lightcatcher
L’ambrotipia è la tecnica con cui il fotografo e cameraman altoatesino Kurt Moser crea i suoi pezzi unici. Per farlo ...

Eugenio Recuenco
Moda e pubblicità sono gli ambiti professionali nei quali si muove l’intemperante e provocatorio fotografo spagnolo Eugenio Recuenco, che illumina ...































