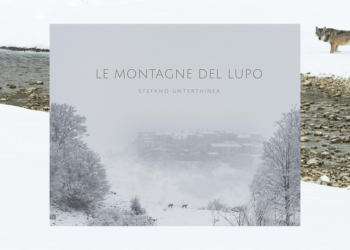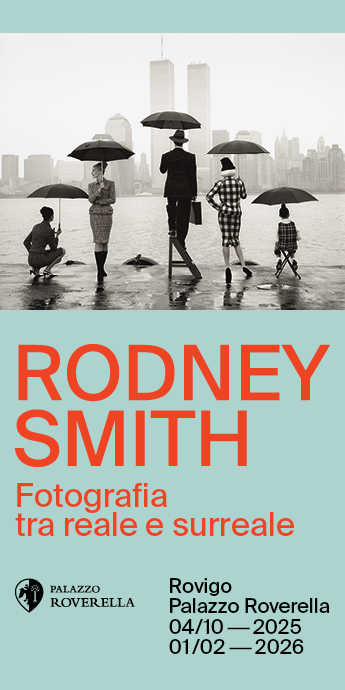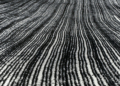Per realizzare Winter Migration of nomad eagle hunters of Western Mongolia, la fotografa Alessandra Manzotti ha percorso centinaia di chilometri con una famiglia della Mongolia Occidentale in migrazione verso luoghi più adatti alla sopravvivenza nella stagione rigida. Animali e persone, in questo lungo viaggio, lottano contro il freddo e la fame, per seguire una tradizione secolare. Con le sue immagini a colori, Alessandra racconta di queste lotte, ma anche delle innumerevoli storie di vita di cui si è resa testimone.
Abbiamo intervistato l’autrice per farci raccontare la sua strepitosa esperienza sul campo.
Quando e come nasce il progetto Winter Migration of nomad eagle hunters of Western Mongolia?
Il progetto è nato sette anni fa quando venni invitata a partecipare a una spedizione inglese il cui obiettivo era quello di documentare la migrazione invernale di una famiglia di nomadi kazaki ‘Eagle Hunters’ della Mongolia Occidentale. Alcuni anni dopo sono ritornata una seconda volta per continuare questo progetto seguendo sempre la stessa famiglia.
Qual è la loro storia?
La famiglia con cui ho fatto la migrazione è quella di Shokhan, della provincia di Banian Ulgii, nei monti Altai della Mongolia Occidentale. Shokhan vive con sua moglie Purna, i suoi cinque figli e suo padre Tabai, famosissimo ‘Eagle Hunter’ e patriarca della famiglia. La loro vita è nomadica pastorale e possiedono una grossa mandria di animali tra cui pecore, capre, mucche, yak, cavalli e cammelli bactriani. Durante l’inverno, nel periodo migratorio, i figli più grandi vengono mandati in collegio nel paese più vicino e tornano a casa solo in estate.
La comunità nomade che hai seguito appartiene a un particolare genere di cacciatori, gli “Eagle hunters”, che cacciano con aquile addestrate. Ci racconti la loro pratica?
Attualmente nella Mongolia Occidentale ci sono circa duecentocinquanta famiglie che praticano ancora la tradizione centenaria di cacciare con le aquile reali. Una femmina di aquila viene prelevata da un nido selvatico quando ancora è giovane e soprattutto quando non è ancora in grado di volare. Vengono addestrate aquile femmine perché sono generalmente più grosse e molto più aggressive dei maschi. Sin dai primi giorni l’aquila viene fatta vivere a stretto contatto con il falconiere, localmente chiamato ‘berkutchi’, in modo che l’animale si abitui alla sua voce e alla sua presenza, e che si instauri un forte legame tra i due.
Il processo di addestramento richiede molti anni e tantissima pazienza. Nel tempo, si crea un forte rapporto di fiducia e di rispetto tra il rapace e l’uomo, e l’aquila impara a cacciare lupi, volpi e lepri, il cui pellame viene utilizzato per creare il tipico abbigliamento invernale. Durante la loro vita in cattività le aquile sono considerate come membri della famiglia e, quando non cacciano o non si allenano, vivono in casa appollaiate su tronchi e incappucciate per farle rimanere calme.
Secondo la tradizione kazaka, dopo circa dieci anni – talvolta anche meno – l’aquila viene rimessa in libertà e come segno di ringraziamento viene portata in cima a una montagna insieme a una capra morta, che le viene offerta.
Per i nomadi kazaki la caccia con l’aquila non è solo una pratica venatoria ma anche un’importantissima tradizione culturale che si tramanda di generazione in generazione.
Mentre in passato l’addestramento di questo rapace era riservato agli uomini, oggigiorno ci sono moltissime giovani donne che lo praticano. Vengono infatti organizzati diversi festival e competizioni per cercare di mantenere viva questa pratica millenaria che lentamente sta sparendo a causa dell’industrializzazione e dell’abbandono della vita nomade da parte delle nuove generazioni.
Hai seguito l’intero viaggio migratorio della famiglia? Come ti sei organizzata, anche dal punto di vista pratico, per rimanere con loro e poterli documentare?
Ogni anno, nei mesi di febbraio e marzo, circa duecento famiglie nomadi che cacciano con le aquile intraprendono una pericolosa migrazione invernale di cinque giorni, lungo un percorso di centocinquanta chilometri, verso il loro campo primaverile, nelle remote alture delle maestose montagne dell’Altai. La loro speranza è quella di trovare pascoli migliori per il loro prezioso bestiame. Rimangono in queste zone per circa tre o quattro mesi, prima di spostarsi verso il loro campo estivo. In media migrano tre o quattro volte l’anno.
Gli inverni sono implacabili, con temperature che scendono fino a quaranta gradi sotto zero e venti forti.
Mentre in passato l’intera famiglia affrontava il viaggio a piedi o a cavallo, oggi le cose sono un po’ diverse: le donne, i bambini molto piccoli e gli anziani viaggiano verso il campo su un camion insieme a tutti gli oggetti della famiglia. Spesso i camion trasportano animali malati, anziani, feriti e cuccioli, che altrimenti non potrebbero sopravvivere. La maggior parte del bestiame, però, generalmente tra i cinquecento e i millecinquecento animali, tra cammelli bactriani, capre, mucche, cavalli e yak, non ha altra scelta che affrontare questo straordinario viaggio a piedi, guidato dai giovani della famiglia a cavallo.
Spesso succede che più famiglie migrino insieme, in modo da unire le forze e aiutarsi in caso di complicazioni.
Noi abbiamo seguito a piedi tutta la migrazione e grazie alla giusta attrezzatura non abbiamo sofferto troppo il freddo. È stata un’esperienza decisamente dura dal punto di vista fisico: in alcune occasioni siamo stati sorpresi da tormente di neve, ad esempio, ma abbiamo sempre trovato cibo caldo e delizioso e alloggi confortevoli, sebbene molto spartani.
Che approccio hai adottato per inserirti al meglio nella loro comunità?
Dal punto di vista logistico e organizzativo è stato tutto molto semplice. Ci siamo avvalsi di un fixer locale che ci ha introdotti nella famiglia e ci ha permesso di comunicare e interagire con loro.
Avevamo con noi un traduttore, un cuoco e due guidatori tutto fare. Il fatto di aver condiviso e partecipato attivamente alla migrazione, spesso aiutando con gli animali che collassavano a causa del freddo e della mancanza di cibo, ci ha permesso di creare un rapporto di fiducia e di complicità che forse in altre circostanze non avremmo raggiunto cosi velocemente. Abbiamo condiviso tantissimo durante la migrazione e questo ha fatto davvero la differenza. Queste famiglie sono tutte estremamente ospitali e sempre pronte a condividere cibo e storie.
Immagino che per fotografare in quelle condizioni ambientali tu abbia avuto al tuo seguito una strumentazione leggera e veloce…
Diciamo che dovendo camminare per circa trenta chilometri al giorno a -35/-40 °C, avere un’attrezzatura comoda e leggera e soprattutto sempre a portata di mano ha fatto la differenza.
Ho usato un’imbracatura fotografica con due corpi macchina agganciati, con batterie di scorta e memory card che ho sempre tenuto a contatto col mio corpo per preservarne la carica ed evitare che congelassero. Ho usato solo due obiettivi per evitare di doverli cambiare mentre camminavo. Avevamo portato un piccolo generatore in modo da poter caricare cellulari e batterie ogni due giorni circa. Al nostro seguito c’era anche un vecchio UAZ, cioè un veicolo militare russo che serviva principalmente per trasportare i nostri borsoni, ma a volte anche animali in difficoltà.
Che tipo di estetica hai perseguito per raccontare il loro viaggio?
Il mio obiettivo principale era documentare al meglio ogni aspetto della migrazione, incorporando un po’ di tutto. Per prima cosa, per me, era importante essere ‘presente’ in questa avventura, godere di tutto quello che vedevo per la prima volta. Avendo tante ore di cammino, spesso da sola, ho avuto il tempo di rallentare tutto, anche gli scatti; di apprezzare il viaggio più che la fotografia, che è arrivata organicamente.
Tutta la zona degli Altai e le sue distese infinite di neve e ghiaccio sono incredibilmente cinematografiche e spesso ho avuto la sensazione di essere dentro il set di un film epico. Vivendola in prima persona, ho cercato di documentare le mie sensazioni ed esperienze al meglio.
Durante i cinque giorni della migrazione sembrava che tutto si muovesse a rallentatore. Ho fotografato senza fretta e con uno scopo ben chiaro: ho cercato di trasmettere la vastità di questi luoghi, il senso di orgoglio che questi nomadi hanno per la loro terra, le loro tradizioni e il loro stile di vita. Sono forti e resilienti, e affrontano spesso le difficoltà con ingegno e determinazione. Inoltre, hanno una profonda connessione con i loro animali e una straordinaria capacita non solo di adattarsi, ma di prosperare in condizioni molto dure.
Quanto la postproduzione influisce nella resa estetica del tuo lavoro?
Credo che la postproduzione sia uno strumento utilissimo per identificare e sviluppare un proprio stile riconoscibile, però non deve diventare ‘una stampella’. Spesso immagini tecnicamente mediocri vengono fortemente postprodotte per cercare di salvare il salvabile. Io cerco sempre di fare il meglio che posso per scattare la foto correttamente e deliberatamente. La postproduzione aiuta a mantenere una certa coesione stilistica e visiva, ma non fa la foto.
Ulteriori informazioni sul lavoro di Alessandra Manzotti sono disponibili sul sito della fotografa, alessandramanzotti.com.
Fotoreporter tra le fiamme della California
Josh Edelson, impavido fotografo di disastri...
Il fotografo dei fantasmi del West americano
“West Safari” di Francesco Aglieri Rinella...
Josh Aronson: non tutti i social network vengono per nuocere
Con le fotografie di "Florida Boys"...
Dagli Appennini alle Alpi: Stefano Unterthiner e “Le montagne del lupo”
Intervista con il fotografo naturalista Stefano...
Piergiorgio Branzi: i primi passi furono verso sud
dal 3 dicembre 2025 al 16...
Roberta Krasnig: il surrealismo si affaccia nella fotografia di moda
Un viaggio nella brillante estetica di...