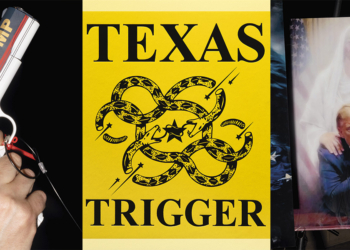Le città si espandono, mutano, e non sempre in meglio. Ai giorni nostri le dinamiche della gentrificazione sono sotto gli occhi di tutti: si piallano interi quartieri per far posto a mostri edilizi, il verde è sempre più un miraggio, aprono luoghi commerciali dove il cibo “esotico” è l’unica attrattiva, chiudono gli artigiani, le vecchie botteghe di mestiere, e le persone vivono schiacciate da una fantomatica idea di rinnovamento, in una rete sociale sempre più inesistente.
Anche a Londra succede questo, anche nella zona a sud-est della capitale dove Nico Froehlich, inglese di seconda generazione, ha sempre vissuto ed è cresciuto desiderando di essere uno dei tanti, di essere accettato e di sentirsi parte di qualcosa. Il suo South of the River è un viaggio introspettivo in quel territorio che è sempre stato “casa” per lui; ne mostra la forza di reazione ai nuovi cambiamenti contemporanei e si sofferma anche sui dettagli che da piccolo l’autore censurava a sé stesso perché gli avrebbero confermato che le sue origini erano altrove. South of the River è, quindi, un omaggio alla sua identità poliedrica, a più voci, a più sguardi, come sua madre gli ha sempre insegnato. Abbiamo intervistato Nico per farci raccontare il suo progetto.
Nella presentazione del tuo lavoro dici che quello che hai fotografato in South of the River è quello che, da bambino, cresciuto in una famiglia di immigrati nel sud-est di Londra, hai cercato di oscurare a te stesso. Cosa non volevi vedere e perché?
È difficile esprimerlo con precisione, ma da bambino ero così concentrato a integrarmi con l’ambiente circostante che cercavo di sopprimere qualsiasi cosa mi identificasse come diverso. Le sfumature culturali, soprattutto da parte di mia madre, mi sembravano ostacoli a ciò che all’epoca consideravo ‘normale’. Desideravo disperatamente inserirmi, senza rendermi conto che proprio quelle differenze mi rendevano tutt’altro che ordinario, e nei modi più meravigliosi. Solo molto più tardi, quando ho iniziato a fotografare, mi sono sentito in dovere di tornare a quei dettagli che un tempo avevo rifiutato. Con la macchina fotografica potevo riformularli, non come qualcosa da nascondere, ma come qualcosa da onorare. L’atto di fotografare è diventato una sorta di riconciliazione, un modo per dire al me stesso più giovane: ‘questa è la tua storia e ha un valore’.
Tu parli di gentrificazione, ma anche di resilienza del territorio e dei suoi abitanti. In cosa, nel tempo, è cambiato il sud-est di Londra? E in cosa differisce rispetto al resto della città?
Il cambiamento è stato radicale. Intere strade sono state trasformate, con bar al posto di vecchie lavanderie e nuovi edifici scintillanti che sorgono dove un tempo c’erano centri comunitari. Eppure, ciò che mi ha colpito di più non è la portata della gentrificazione, ma la forza di adattamento di chi è rimasto, senza farsi schiacciare. Le persone hanno resistito alle numerose ondate di cambiamento, ma il loro spirito – l’umorismo, la grinta, la solidarietà inespressa – continua a essere il fulcro di questa comunità.
Il sud-est di Londra ha sempre avuto una certa tenacia, anche se è una zona trascurata e sottorappresentata rispetto al resto della città e, anzi, forse proprio su queste mancanze ha basato la sua forza. Questa tenacia ha generato una profonda resilienza. Anche se alcune parti vengono rimodellate e ripensate, l’essenza del luogo si rifiuta di scomparire. È quella caparbia vitalità, quella capacità di adattarsi senza perdere identità, che rende la zona diversa da qualsiasi altra a Londra.
Nel titolo del tuo lavoro citi “il fiume”, riferendoti al Tamigi. Lo hai fatto solo per connotare geograficamente il progetto?
Il Tamigi è più di un semplice indicatore geografico perché è sempre stato anche un confine psicologico. Crescendo, sentivo spesso storie di tassisti neri che rifiutavano la corsa, dicendo che non andavano a sud del fiume, come se fosse una zona vietata. È diventato quasi un cliché nella cultura londinese, ma come la maggior parte dei cliché, conteneva un fondo di verità.
Quindi, per me, il fiume simboleggia più della geografia. Rappresenta l’identità, l’emarginazione e l’idea di essere ‘dall’altra parte’. Anche se raramente compare nell’opera stessa, la sua presenza si percepisce in ogni immagine. Il fiume è la linea invisibile che ha plasmato le vite e le percezioni di coloro che sono cresciuti lì.
Il tuo lavoro è un incontro di stili, dal documentaristico al simbolico, dal concettuale all’architettonico. Come hai strutturato il loro dialogo? Con che finalità?
Per me si è sempre trattato di narrazione. Il sud-est di Londra non è unidimensionale: è stratificato, disordinato e pieno di contraddizioni, quindi volevo che il lavoro riflettesse questa ricchezza. La varietà visiva era essenziale: la documentazione mi ha dato il fondamento della realtà, il simbolismo mi ha permesso di suggerire significati più profondi, mentre l’inquadratura architettonica e gli approcci concettuali hanno aggiunto ritmo e struttura.
Piuttosto che forzare tutto in un unico stile, ho lasciato che le diverse modalità di creazione delle immagini si affiancassero, dialogando tra loro. Questa varietà rispecchia l’esperienza stessa di camminare per le strade della zona, passando dall’intimo al sociale, dal quotidiano al poetico. Inoltre, mantiene lo spettatore coinvolto, come se stesse ricomponendo frammenti di una storia più ampia, trovando il proprio filo conduttore attraverso l’opera.
L’utilizzo della luce è un elemento importante del tuo progetto. Ce ne parli?
Per me la luce è sia una scelta stilistica che un espediente narrativo. La uso con grande attenzione, non solo per dare forma all’estetica dell’immagine, ma anche per infonderle un senso di speranza. Per molti versi, questa speranza rispecchia la perseveranza e la positività che ho sempre associato alle comunità operaie. Anche nei contesti più ordinari o trascurati, la luce ha il potere di trasformare, di rivelare dignità, resilienza e bellezza dove qualcuno potrebbe inizialmente non guardare. Per me, è un modo per dire che, per quanto difficili siano le circostanze, c’è sempre uno splendore da trovare, e merita di essere visto.
Le insegne compaiono spesso nelle tue immagini, per rappresentare la dimensione commerciale del territorio. Quanto di Walker Evans c’è nelle tue fotografie?
A dire il vero, non conosco particolarmente bene il lavoro di Walker Evans, anche se la tua domanda mi ha sicuramente incuriosito. Da quello che so, la sua capacità di intrecciare segni e dettagli quotidiani in qualcosa di culturalmente significativo è affascinante.
Nelle mie fotografie, i segni sono meno un riferimento consapevole a Evans e più una parte naturale dell’ambiente che mi attrae. Portano con sé frammenti della storia e dell’identità di un luogo, spesso trascurati, che dicono tanto di una comunità quanto delle persone stesse.
Quali fotografi, nel corso della tua carriera, ti hanno particolarmente influenzato?
Ce ne sono tantissimi, ma alcuni si distinguono per il modo in cui hanno plasmato il mio modo di vedere e realizzare il mio lavoro. Evelyn Hofer, per la sua sensibilità silenziosa, quasi pittorica, verso le persone e i luoghi. Paul Graham, per la sua capacità di sfumare i confini tra documentario e arte in modo così lirico. Bruce Davidson e Gordon Parks, che mi hanno mostrato che la fotografia può essere socialmente impegnata ed empatica allo stesso tempo. E Chris Killip, il cui lavoro crudo ma profondamente umano sulla Gran Bretagna della classe operaia mi ha sempre colpito. Oltre alla fotografia, ho tratto ispirazione anche dal realismo sociale britannico nel cinema, in particolare da registi come Andrea Arnold e Ken Loach. I loro film hanno la stessa incrollabile onestà, ma anche una profonda compassione per la vita quotidiana. Questo equilibrio tra realismo e umanità è qualcosa che cerco di trasferire nel mio lavoro.
C’è una foto, in particolare, che si distingue per composizione e delicatezza. Sembra un’icona religiosa. La donna girata di spalle in cucina con un foulard rosa in testa. Ci racconti di quell’immagine?
In quella foto ho ritratto mia madre, ed è una delle immagini più personali che abbia mai scattato. Non è in posa, è semplicemente assorta in un momento quotidiano, ma la luce e il suo gesto silenzioso la elevano a qualcosa di quasi sacro. Per me, simboleggia la forza e la grazia delle donne immigrate che hanno tenuto unite le famiglie in circostanze difficili. È anche una delle principali fonti di ispirazione per tutto il mio lavoro. Ciò che mi ha sempre ispirato è il fatto che abbia vissuto la sua vita senza scuse e senza compromessi, rimanendo sé stessa. Questo spirito – di dignità, perseveranza e autenticità – permea la mia pratica. Per molti versi, fotografarla non è stato solo un atto d’amore, ma un modo per riconoscere che i valori che porto nel mio lavoro sono stati plasmati dal suo esempio fin dall’inizio.
Ulteriori fotografie e informazioni sul lavoro di Nico Froehlich sono disponibili sul sito del fotografo, nicofroehlich.com.
Street photography a Brooklyn con una toy camera
“Wonderland” è il progetto di Valery...
Sconosciuti su foglia d’oro: le affascinanti fotografie anonime collezionate da Lee Shulman
L’Artiere pubblica “Golden Moemories”, il libro...
Texas Trigger: un flash spietato sulla caricatura di Donald Trump e della sua America
Il libro di Santese e Valli...
Dekotora: camion giapponesi tra kitsch e cinema
Con fotografie dall’atmosfera cinematografica Todd Antony...
Fotoreporter tra le fiamme della California
Josh Edelson, impavido fotografo di disastri...
Il fotografo dei fantasmi del West americano
“West Safari” di Francesco Aglieri Rinella...